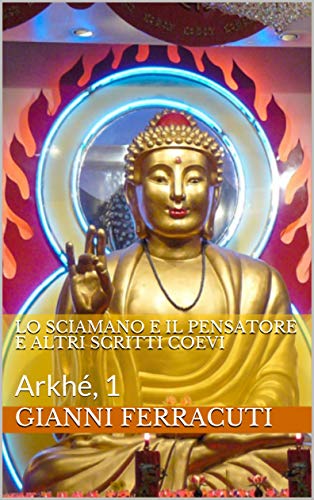Don Chisciotte e l’islam (Il gran mondo del teatro e alcune eccellenti ragioni per cui al saggio governante conviene eliminare i comici…)
Qui comincia l’avventura…
o Sarajevo blues
Per il cavaliere dei romanzi, quello che – secondo gli uomini di sano buon senso – non esiste nella storia, la guerra è un dato di fatto: la combatte, ma non rappresenta l’istanza superiore. Al di sopra della guerra, come la intendono gli eserciti, ci sono le virtù cavalleresche, che non sono solo virtù militari. Nella guerra il cavaliere non cerca la ricchezza, né il potere: cerca la gloria. Battere un uomo debole non è impresa di valore, non procura gloria né fama, anche se potrebbe portare un discreto bottino. Piuttosto se si vuole mostrare al mondo il proprio coraggio e la qualità della propria sostanza umana, è più proficuo mettersi davanti a un ponte e imporre al viandante che lodi la propria dama, alla cieca: se lo fa, vuol dire che nel suo cuore non albergano valori cavallereschi, e non vale la pena di battersi con lui. Se non lo fa, vuol dire che ha fegato, che accetta di spezzare una lancia in duello a rischio di rimetterci qualche osso, e dunque ha un coraggio con cui ci si può misurare.
Con ciò si produce un’altra possibilità: un tizio sconosciuto, che mai avrebbe pensato di recarsi proprio presso quel ponte insignificante e anonimo, viene a sapere della sfida e sconvolge tutti i piani della sua esistenza per andare proprio lì, su un ponte che non porta a nulla, sopra un fiumiciattolo ignaro e fangoso, solo per poter dire in faccia a un illustre ignoto che non ha alcuna intenzione di lodare la sua dama, neanche se fosse la regina di Cappadocia. Potrà stupire la stranezza, ma la cosa è storica, è avvenuta più volte, ed è una sindrome che ha un nome ben preciso: avventura.[1]
Circa quattro secoli fa, un oscuro idalgo di paese, di cui le cronache parlano poco e confusamente, al punto che abbiamo faticato molto per conoscerne il nome, decide di lasciarsi alle spalle una vita non lussuosa, ma tranquilla e, nonostante la non giovanile età di cinquant’anni, esce di casa silenziosamente nella notte e va in cerca di avventure. Rinuncia alla sua identità, al suo ruolo sociale, peraltro ormai vago e prossimo all’insignificanza, e assume il nome di battaglia di Don Chisciotto della Mancia. Cattivi traduttori hanno diffuso il suo nome nella forma Chisciotte, che ormai è talmente generalizzata nell’uso che non vale la pena di provare a cambiarla. Habent sua fata libelli, commentò il retore citando il poeta latino (c’è sempre un poeta latino per ogni occasione).
Il nostro eroe si prepara per giorni segretamente, consapevole dell’impossibilità che le ristrette menti dei suoi familiari possano comprendere la nobiltà e la grandezza del suo disegno, e infine si chiude delicatamente la porta dietro le spalle, conduce piano il suo destriero a debita distanza da casa, per non farsi sentire, quindi gli sale in groppa e si allontana.
La storia è raccontata da una cronaca scritta in arabo da un tale Cide Hamete Benengeli, di cui ci è pervenuta solo una redazione in castigliano, elaborata a partire da una traduzione intermedia fatta da un anonimo traduttore in cambio di pochi spiccioli. Noi, che utilizziamo alcune fonti inedite, fortunosamente giunte in nostro possesso, possiamo garantire che, prima di allontanarsi con una galoppata propiziatoria, il nostro don Chisciotte ha fatto una piccola deviazione per dare un ultimo sguardo al Toboso, terra della sua amata signora Dulcinea, alla quale avrebbe poi mandato, per renderle omaggio, tutti gli avversari sconfitti a singolar tenzone.
In quel tempo il Toboso doveva avere un aspetto diverso dall’attuale. Terra ad alta densità moresca,[2] sarà stato decorato da qualche minareto ancora in piedi e dalle tombe di gente sepolta alla maniera dei musulmani: basse colonne che spuntano da terra non nei cimiteri, ma nei giardini delle moschee, o dove capita, senza un ordine particolare. Per vedere qualcosa di simile bisogna andare oggi a Sarajevo, arrivarci magari all’imbrunire di una giornata uggiosa, camminare per strade che non sembrano diverse da quelle abituali dei nostri paesi, a parte qualche rudere lasciato dalla guerra e rimasto in piedi per caso, e sorprendersi ascoltando improvvisamente la lenta litania di una preghiera araba che giunge da una moschea nascosta dietro l’angolo. Alcune donne col chador escono per la preghiera della sera e, andando verso il centro, si fiancheggia un giardino pubblico in cui, a gruppi di quattro o cinque, si vedono spuntare da terra queste strane, basse colonne di marmo bianco. Si trovano dovunque, intorno a ogni moschea e, salendo verso la parte collinare della città, decorano ogni metro quadrato di verde, a volte con una densità impressionante, che gela il sangue: sotto ogni colonna c’è una vita, generalmente giovane, spezzata da un cecchino durante l’assedio della città – si sparava ai musulmani perché erano musulmani. A centinaia di chilometri di distanza, si sparava su ogni casa di Dubrovnik, perché era bella, antica, e significante: due assedi, due atti di una stessa follia, e non si dà l’uno senza l’altro. Se si vuole ammazzare un tizio perché ha una fede, una credenza, una cultura, bisogna eliminare lui, la sua casa, la sua storia, la sua famiglia, il suo giardino, la sua memoria, i suoi animali, i suoi simboli, le sue biblioteche, la sua musica e persino le sue nevrosi…
Le piccole tombe islamiche del Toboso non erano recenti, anche se costituivano un’immagine abituale. Dopo la caduta del regno di Granada (1492) – quasi ridotto a un museo, a un fossile politico, impossibilitato a essere a una forza preoccupante, eppur capace di resistere una decina d’anni all’esercito castigliano – gli spagnoli cristiani si rimangiano presto la promessa di consentire la libera pratica della religione islamica a quei cittadini islamici di Spagna, che erano loro concittadini; tentano una maldestra opera di evangelizzazione, servendosi peraltro di un clero non all’altezza e non credibile, e infine iniziano a prendere misure di pulizia etnica, sradicando per legge ogni usanza legata ai costumi islamici. Erano terre da ripulire – alimpiar, potremmo dire usando un verbo già sentito dalla bocca della regina Isabel e rivolto alla necessità di ripulire il territorio dalla presenza dei suoi concittadini spagnoli di religione ebraica: a quell’epoca era divenuta fondamentale la limpieza de sangre, la pulizia del sangue… e siccome il sangue, nella società in cui si è nobili per diritto ereditario, è ciò che trasmette i valori e le virtù della famiglia e della stirpe, o ethnos, non è sbagliato tradurre limpieza de sangre con pulizia etnica.[3]
Rivolgendo un ultimo saluto alla sua Dulcinea, don Chisciotte si muove senza alcun imbarazzo tra le piccole colonne sparse nel paesaggio. Dulcinea del Toboso è una nobile e bellissima dama, il cui rango è almeno principessa, perché tale è il livello ideale a cui la cortese arte cavalleresca di don Chisciotte ha innalzato la robusta contadinotta Aldonza Lorenzo… ahimè, senza preoccuparsi minimamente del suo lignaggio e del suo sangue. Queste cose non hanno alcuna importanza nel mondo dell’avventura – pensa saggiamente il nostro cavaliere. Si sbaglia.
[Introduzione a Gianni Ferracuti: Don Chisciotte e l’islam (Il gran mondo del teatro e alcune eccellenti ragioni per cui al saggio governante conviene eliminare i comici...), disponibile online in ebook e cartaceo su Amazon.it
[1] Suero de Quiñones (c. 1409-1456), nobile leonese di famiglia altolocata, nel 1434 su un ponte sul fiume Órbigo, lungo il Camino de Santiago, sfidò a tenzone tutti i cavalieri che volessero attraversarlo. Nell’arco di un mese vinse dozzine di sfide senza mai perdere, finché non fu obbligato dalle autorità (in particolare da Álvaro de Luna) ad abbandonare il passo. La sua storia è raccontata nel Libro del paso honroso defendido por el excelente caballero Suero de Quiñones di Pero Rodríguez de Lena (Pero Rodríguez de Lena, El passo honroso de Suero de Quiñones, ed. Amancio Labandeira Fernández, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1977). Suero è citato nel Don Quijote, I, 49 (Tutte le citazioni del Don Chisciotte sono tratte dall’edizione curata da Martín de Riquer: Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Planeta, Barcelona 1975, indicata con l’abbreviazione DQ, seguita dal numero romano indicante la parte Prima o Seconda e dalla cifra araba indicante il capitolo. Le traduzioni dei testi citati sono mie, salvo indicazione contraria). Nel capitolo citato, discutendo con un canonico di Toledo, Don Chisciotte dichiara che le avventure cavalleresche sono vere appunto come le sfide di Suero. Commenta Francisco Rico: «Suero de Quiñones, discreto poeta, non osò scrivere le sue prodezze: si accontentò di viverle avendo ben cura che un notaio le registrasse con ogni dettaglio; e infatti il registro, riassunto venne stampato negli stessi giorni in cui si svolge l’azione dell’Ingegnoso hidalgo […]. Non è facile dire se Suero difese il Passo per il gusto di contenderlo o per diventare protagonista di un racconto. Le due cose vanno di pari passo. Comunque sia, di don Chisciotte ci risulta che, prima di intraprendere la sua prima uscita, aveva pensato di concludere un libro di cavalleria, l’incompiuto Belianís de Grecia, e soprattutto che proprio all’inizio delle sue peripezie ciò che vedeva con maggior chiarezza nella sua immaginazione era la cronaca che “nei tempi futuri” un “sapiente” avrebbe dedicato alla “vera storia delle mie famose azioni” [DQ I, 2]. Come tanti cavalieri precedenti, e successivi, don Chisciotte esce da certi libri mosso dal desiderio di diventare eroe di altri» (Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, ed. Francisco Rico, Alfaguara, Madrid 2013, ebook; edizione cartacea: 2015).
[2] Antonio Domínguez Ortiz, Bernard Vincent, Historia de los moriscos: vida y tragedia de una minoría, Alianza, Madrid 1993; Francisco Javier Moreno Díaz, Los moriscos de la Mancha: sociedad, economía y modos de vida de una minoría en la Castilla moderna, CSIC, Madrid 2009. William Byron, Cervantes, a Biography, Cassell, London 1979, p. 472, stima che con l’espulsione dei moriscos il Toboso avrebbe perso circa un terzo dei suoi abitanti.
[3] Nel XV secolo si generalizza l’idea del carattere ereditario della nobiltà. «Il problema era […] la scelta tra ereditare la nobiltà – l’acquisizione passiva dello status nobiliare – o, al contrario, la capacità di acquisire la nobiltà – di ottenere tale status per meriti propri. […] L’importanza del sangue come elemento dell’acquisizione e della trasmissione della condizione nobiliare era indiscutibile. In questo contesto venne affermato il valore dell’ereditarietà in sé, istituendo la particolare struttura familiare nobiliare come cornice in cui erano depositati tutti i valori, generazione dopo generazione. Secondo questa ottica, era il lignaggio, non l’individuo, il garante dell’essenza nobiliare» [María Concepción Quintanilla Raso, «Nobilitas virtutis causa: de la virtud al pecado en la nobleza», in Ana Isabel Carrasco Manchado, María del Pilar Rábade Obradó (eds.), Pecar en la Edad Media, Sílex, Madrid 2008, pp. 145-81, p. 156]. Singolarmente, l’idea che il lignaggio garantisca l’essenza nobiliare si ritrova sia in chi fonda il valore della nobiltà sull’eredità, sia in chi la fonda sulle virtù personali: in questo secondo caso, infatti, l’emergere di qualità nobiliari nell’individuo è visto come il venire alla luce del valore già presente nella propria stirpe. Nella seconda parte del Don Chisciotte, il Cavaliere afferma l’esistenza di un tipo di lignaggio che ha avuto origini oscure e poi è cresciuto in grandezza e onori, alludendo appunto a un lignaggio, una stirpe, e non un passaggio personale dalla condizione plebea a quella nobiliare: dice infatti, nello stesso luogo, «del lignaggio plebeo posso dire soltanto che serve solo ad aumentare il numero di coloro che vivono, senza merito di ulteriore fama o elogio» (DQ, II, 6). In vari passi Don Chisciotte ipotizza che un sapiente possa scoprire l’origine regale della sua stirpe, della quale al momento lui non è a conoscenza, ma che può essere ipotizzata proprio grazie al valore delle imprese che sta compiendo (ad esempio DQ, 1, 21: «Potrà essere che il sapiente che scriverà la mia storia potrà puntualizzare in tal modo la mia parentela o discendenza da scoprirmi quinto o sesto nipote di re»).